NOTIZIE DAL SITO
http://carlogesualdo.altervista.org
di: Franco Caracciolo
Gesualdo (av)
A GESUALDO, UNA STRADA PER LEONORA D’ESTE
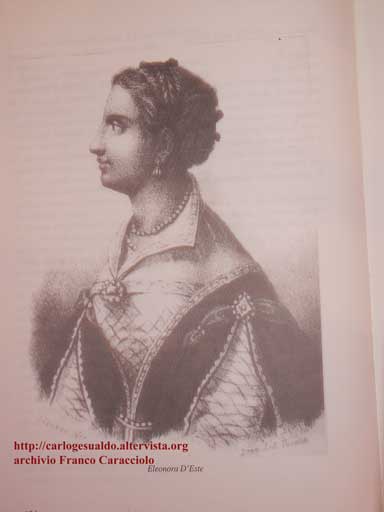 Il 3
settembre 1613 Carlo Gesualdo, avvertendo l’approssimarsi della morte, nella
pienezza Delle sue capacità di intendere e di volere, dettò il suo ultimo
testamento. Secondo la mentalità dei tempi passati, prima di ordinare le messe
perpetue per la salvezza della sua anima, implorò “all’Onnipotente Iddio” il
perdono dei suoi peccati affinché la sua anima potesse godere la luce eterna.
Perché la sua supplica fosse ben accetta, invocò l’intercessione della vergine
Maria, degli apostoli Pietro e Paolo, San Michele Arcangelo, San Domenico, Santa
Maria Maddalena, e Santa Caterina da Siena. Nella lista dei santi destinati a
patrocinare l’ammissione alla vita eterna, presso la “Divina Maestà”, manca San
Carlo Borromeo (1538 – 1584). Il santo era zio materno del principe di Venosa e
fu canonizzato il 1° novembre 1610, essendo arcivescovo di Milano, il cardinale
Federico Borromeo, eccelso prelato fondatore della Biblioteca Ambrosiana e
cugino del Santo. E’ stupevole che il nostro principe escludesse dal collegio
dei Santi patrocinatori proprio il suo amato zio, per il quale con lettera al
cardinale Federico Borromeo del 25 Ottobre 1610 chiedeva l’invio di “un
ritratto naturale del gloriosissimo S. Carlo …(anzi) il più naturale
possibile, perché possa farne cavare un quadro grande, per adempiere al suddetto
desiderio.” Oltre all’intento di ordinare un grande quadro pittorico, il
Gesualdo bramava conoscere le sembianze del beato zio per meglio indirizzargli
le preghiere. Al momento non si sa se Federico Borromeo esaudì la richiesta, ma
un fatto emerge chiaro e lampante: fino a tutto il 1610 Carlo Gesualdo non
disponeva di immagini di S. Carlo Borromeo. Se si trascura la cronologia la
Storia si allontana dalle sue funzioni e si fa romanzo. Carlo Gesualdo eluse la
tutela di San Carlo nel viatico della sua anima, poiché sapeva che quel parente
santo non avrebbe mai barattato per la remissione dei suoi peccati di
coscienza. Il “Principe dei musici” aveva fatto uccidere la sua prima sposa e
il di lui amante, ma quel duplice delitto allora non era punibile, poiché le
leggi e il senso comune esigevano l’obbligatorietà della punizione nei
confronti degli adulteri sorpresi in flagranza. Fu fedigrafo nei confronti di
Leonora d’Este fornicando con le sue belle e giovani cortigiane e coll’aitante
Castelvietro, ma, tenendo conto della maggiore età di Leonora, anche quegli
amorazzi, in quei tempi, erano ritenuti lecite trasgressioni. Il Principe Carlo
a Venosa procreò Antonio Gesualdo, figlio non legittimo, il quale divenne
pericoloso molestatore di fanciulle, ma secondo i parametri morali dell’epoca,
generare figli spuri non era nemmeno censurabile. D’altra parte, escludendo la
colpa originale, anche S. Paolo era convinto che il concetto di peccato dipende
dalle convenzioni, tanto è vero che nell’ Epistola ai Romani dice: “ Io
conobbi il peccato dopo la legge”. Ossia, il reato è inconcepibile senza
prescrizione legislativa. Carlo Gesualdo, pur continuando a gestire i suoi atti
secondo i cerimoniosi ossequi, tipici della nobiltà, giunto alla “resa dei
conti” capì quanto era lontano e diverso dal milanese zio santo. San Carlo
Borromeo spese le sue ricchezze per i poveri e per gli infelici, ai quali,
lasciò in eredità il suo patrimonio legandolo all’Ambrosiano Ospedale Maggiore.
Fu sostenitore dei Monti di Pietà e promotore del gratuito patrocinio degli
indigenti. Riformò il Pio Istituto di Santa Corona per i malati miseri, fondò
il Consorzio dei Disciplini per l’ultimo conforto ai condannati a morte. Aprì
scuole e collegi, edificò case e ricoveri di ogni sorta, tra cui il Santa Maria
Maddalena di Milano, detto il Deposito, ove erano alloggiate le donne di
strada, come capo del clero milanese si prodigò per l’assistenza agli appestati
durante le carestie degli anni 1576-1577, anni in cui potenziò il manzoniano
lazzaretto, vendendo, per quella occasione, il Principato d’Oria e distribuendo
ai bisognosi i 40.000 ducati percepiti. Carlo Gesualdo conosceva vita e
miracoli del suo illustrissimo parente, ma pur essendo immensamente più ricco
si astenne da qualsiasi benefica iniziativa a favore dei diseredati. Le grazie
e i condoni che concesse in punta di morte, rientravano nella regolare prassi
feudale, anzi fu solo negli ultimi giorni del trapasso a ricordarsi che il
padre Fabrizio II° aveva destinato un fondo di 10.000 ducati, con i frutti del
quale avrebbe dovuto costruire chiesa e convento dei Cappuccini di Gesualdo,
nonché distribuire i frutti di un altro fondo, ai poveri di tutte le città,
terre (paesi) e casali dello Stato di Venosa. Nel suo testamento il Principe
Carlo, oltre a destinare cospicue somme per salvare la sua anima ordinando
messe perpetue, vincolò ingentissime somme di danaro a tutti i suoi congiunti e
diede buone liquidazioni ai suoi fidi dipendenti. Come fece a mettere insieme
tanta liquidità finanziaria, che ammontava a circa due milioni e mezzo di
ducati? Carlo Gesualdo, superando i suoi avi, ammassò denaro praticando il
detto che “li soldi fanne ati soldi”, mentre si sa che in epoche
contigue i Caracciolo di Avellino, già dal 1581, col principe Marino, diedero
impulso a grande espansione economica ed edilizia e a copiosa fioritura
artistica. Riattivarono la Dogana, incrementarono mulini e gualchiere,
costruirono strade e acquedotti ed accrebbero la popolazione; benché anche gli
Imperiali, in epoca successiva, a Sant’Angelo dei Lombardi ed altri feudi
introdussero ricchezza con razionali tecniche, nell’agricoltura e negli
allevamenti, nessuna attività produttiva svolse il nostro Principe. I Gesualdo
erano consapevoli che con l’agricoltura, gli allevamenti e i diritti di
monopoli (Jus prohibendi), ed altri privilegi feudali non
sarebbero arrivati troppo in alto, poiché l’unico negozio redditizio era il
commercio del denaro proveniente dalla giurisdizione, che bisognava comprare
anche quando i feudi appartenevano ad altri. Ma cos’era la giurisdizione? La
giurisdizione era un titolo di proprietà trasferibile, per vendita, donazione o
eredità come qualsiasi altro bene privato. Il dominio della giurisdizione
conferiva al titolare l’amministrazione della giustizia civile, criminale
(penale) e mista. Quest’ultima così chiamata, quando nello stesso luogo
esercitavano giudizi, il Sovrano, il clero secolare ed il Comune, che allora si
chiamava Università. Che i Principi Gesualdo privilegiassero l’acquisto delle
giurisdizioni, si evince anche leggendo i libri che si riferiscono alle
famiglie feudali napoletane, ove in rapporto ai feudi posseduti dalla dinastia
dei Conti di Conza, c’è chi parla di 42 e chi di 102, forse tenuto conto della
titolarità delle giurisdizioni. L’entità dei profitti di quella prerogativa
feudale, si può immaginare leggendo il codicillio del testamento del Principe
musicista del 3 Settembre 1613, ove all’articolo 7 il testatore concede grazia
ad Albero Cerulli di Taurasi, il quale fu multato per 600 ducati “per
avergli trovato in casa armi proibite”. La grazia consiste in questo:
che “gli eredi suoi (cioè i Gesualdo) non debbono chiedere
di più dallo stesso Cerulli”. Per chi volesse capire la enormità della
multa inflitta al malcapitato Cerulli, per essere stato trovato con qualche
archibugio senza il relativo porto d’arme, ricordo che se quello sfortunato
facesse il “bracciale” come il novanta per cento della popolazione d’allora,
avrebbe dovuto lavorare trenta anni, senza mai mangiare bere vestirsi e soprattutto
ammalarsi. Certamente il Principe di Venosa, durante la stesura del testamento,
per fare un po’ di beneficenza, oltre a ricordarsi vagamente dello zio San
Carlo, capì che le bestemmie del Cerulli avrebbero vanificato le migliaia di
migliaia di messe che aveva ordinato per la salvezza dell’anima sua. Più degli
antenati del casato, Carlo da Venosa, aveva smodato attaccamento al danaro,
tanto è che nutriva persino antipatia per la povera gente che abitava nei paesi
dove i guadagni della giurisdizione erano scarsi. I poverissimi del vicino
paese di Montefuscolo (Montefusco), paradossalmente, proprio per questo furono
esclusi dalla distribuzione dell’elemosina, nel testamento già innanzi, più
volte riferito.
Il 3
settembre 1613 Carlo Gesualdo, avvertendo l’approssimarsi della morte, nella
pienezza Delle sue capacità di intendere e di volere, dettò il suo ultimo
testamento. Secondo la mentalità dei tempi passati, prima di ordinare le messe
perpetue per la salvezza della sua anima, implorò “all’Onnipotente Iddio” il
perdono dei suoi peccati affinché la sua anima potesse godere la luce eterna.
Perché la sua supplica fosse ben accetta, invocò l’intercessione della vergine
Maria, degli apostoli Pietro e Paolo, San Michele Arcangelo, San Domenico, Santa
Maria Maddalena, e Santa Caterina da Siena. Nella lista dei santi destinati a
patrocinare l’ammissione alla vita eterna, presso la “Divina Maestà”, manca San
Carlo Borromeo (1538 – 1584). Il santo era zio materno del principe di Venosa e
fu canonizzato il 1° novembre 1610, essendo arcivescovo di Milano, il cardinale
Federico Borromeo, eccelso prelato fondatore della Biblioteca Ambrosiana e
cugino del Santo. E’ stupevole che il nostro principe escludesse dal collegio
dei Santi patrocinatori proprio il suo amato zio, per il quale con lettera al
cardinale Federico Borromeo del 25 Ottobre 1610 chiedeva l’invio di “un
ritratto naturale del gloriosissimo S. Carlo …(anzi) il più naturale
possibile, perché possa farne cavare un quadro grande, per adempiere al suddetto
desiderio.” Oltre all’intento di ordinare un grande quadro pittorico, il
Gesualdo bramava conoscere le sembianze del beato zio per meglio indirizzargli
le preghiere. Al momento non si sa se Federico Borromeo esaudì la richiesta, ma
un fatto emerge chiaro e lampante: fino a tutto il 1610 Carlo Gesualdo non
disponeva di immagini di S. Carlo Borromeo. Se si trascura la cronologia la
Storia si allontana dalle sue funzioni e si fa romanzo. Carlo Gesualdo eluse la
tutela di San Carlo nel viatico della sua anima, poiché sapeva che quel parente
santo non avrebbe mai barattato per la remissione dei suoi peccati di
coscienza. Il “Principe dei musici” aveva fatto uccidere la sua prima sposa e
il di lui amante, ma quel duplice delitto allora non era punibile, poiché le
leggi e il senso comune esigevano l’obbligatorietà della punizione nei
confronti degli adulteri sorpresi in flagranza. Fu fedigrafo nei confronti di
Leonora d’Este fornicando con le sue belle e giovani cortigiane e coll’aitante
Castelvietro, ma, tenendo conto della maggiore età di Leonora, anche quegli
amorazzi, in quei tempi, erano ritenuti lecite trasgressioni. Il Principe Carlo
a Venosa procreò Antonio Gesualdo, figlio non legittimo, il quale divenne
pericoloso molestatore di fanciulle, ma secondo i parametri morali dell’epoca,
generare figli spuri non era nemmeno censurabile. D’altra parte, escludendo la
colpa originale, anche S. Paolo era convinto che il concetto di peccato dipende
dalle convenzioni, tanto è vero che nell’ Epistola ai Romani dice: “ Io
conobbi il peccato dopo la legge”. Ossia, il reato è inconcepibile senza
prescrizione legislativa. Carlo Gesualdo, pur continuando a gestire i suoi atti
secondo i cerimoniosi ossequi, tipici della nobiltà, giunto alla “resa dei
conti” capì quanto era lontano e diverso dal milanese zio santo. San Carlo
Borromeo spese le sue ricchezze per i poveri e per gli infelici, ai quali,
lasciò in eredità il suo patrimonio legandolo all’Ambrosiano Ospedale Maggiore.
Fu sostenitore dei Monti di Pietà e promotore del gratuito patrocinio degli
indigenti. Riformò il Pio Istituto di Santa Corona per i malati miseri, fondò
il Consorzio dei Disciplini per l’ultimo conforto ai condannati a morte. Aprì
scuole e collegi, edificò case e ricoveri di ogni sorta, tra cui il Santa Maria
Maddalena di Milano, detto il Deposito, ove erano alloggiate le donne di
strada, come capo del clero milanese si prodigò per l’assistenza agli appestati
durante le carestie degli anni 1576-1577, anni in cui potenziò il manzoniano
lazzaretto, vendendo, per quella occasione, il Principato d’Oria e distribuendo
ai bisognosi i 40.000 ducati percepiti. Carlo Gesualdo conosceva vita e
miracoli del suo illustrissimo parente, ma pur essendo immensamente più ricco
si astenne da qualsiasi benefica iniziativa a favore dei diseredati. Le grazie
e i condoni che concesse in punta di morte, rientravano nella regolare prassi
feudale, anzi fu solo negli ultimi giorni del trapasso a ricordarsi che il
padre Fabrizio II° aveva destinato un fondo di 10.000 ducati, con i frutti del
quale avrebbe dovuto costruire chiesa e convento dei Cappuccini di Gesualdo,
nonché distribuire i frutti di un altro fondo, ai poveri di tutte le città,
terre (paesi) e casali dello Stato di Venosa. Nel suo testamento il Principe
Carlo, oltre a destinare cospicue somme per salvare la sua anima ordinando
messe perpetue, vincolò ingentissime somme di danaro a tutti i suoi congiunti e
diede buone liquidazioni ai suoi fidi dipendenti. Come fece a mettere insieme
tanta liquidità finanziaria, che ammontava a circa due milioni e mezzo di
ducati? Carlo Gesualdo, superando i suoi avi, ammassò denaro praticando il
detto che “li soldi fanne ati soldi”, mentre si sa che in epoche
contigue i Caracciolo di Avellino, già dal 1581, col principe Marino, diedero
impulso a grande espansione economica ed edilizia e a copiosa fioritura
artistica. Riattivarono la Dogana, incrementarono mulini e gualchiere,
costruirono strade e acquedotti ed accrebbero la popolazione; benché anche gli
Imperiali, in epoca successiva, a Sant’Angelo dei Lombardi ed altri feudi
introdussero ricchezza con razionali tecniche, nell’agricoltura e negli
allevamenti, nessuna attività produttiva svolse il nostro Principe. I Gesualdo
erano consapevoli che con l’agricoltura, gli allevamenti e i diritti di
monopoli (Jus prohibendi), ed altri privilegi feudali non
sarebbero arrivati troppo in alto, poiché l’unico negozio redditizio era il
commercio del denaro proveniente dalla giurisdizione, che bisognava comprare
anche quando i feudi appartenevano ad altri. Ma cos’era la giurisdizione? La
giurisdizione era un titolo di proprietà trasferibile, per vendita, donazione o
eredità come qualsiasi altro bene privato. Il dominio della giurisdizione
conferiva al titolare l’amministrazione della giustizia civile, criminale
(penale) e mista. Quest’ultima così chiamata, quando nello stesso luogo
esercitavano giudizi, il Sovrano, il clero secolare ed il Comune, che allora si
chiamava Università. Che i Principi Gesualdo privilegiassero l’acquisto delle
giurisdizioni, si evince anche leggendo i libri che si riferiscono alle
famiglie feudali napoletane, ove in rapporto ai feudi posseduti dalla dinastia
dei Conti di Conza, c’è chi parla di 42 e chi di 102, forse tenuto conto della
titolarità delle giurisdizioni. L’entità dei profitti di quella prerogativa
feudale, si può immaginare leggendo il codicillio del testamento del Principe
musicista del 3 Settembre 1613, ove all’articolo 7 il testatore concede grazia
ad Albero Cerulli di Taurasi, il quale fu multato per 600 ducati “per
avergli trovato in casa armi proibite”. La grazia consiste in questo:
che “gli eredi suoi (cioè i Gesualdo) non debbono chiedere
di più dallo stesso Cerulli”. Per chi volesse capire la enormità della
multa inflitta al malcapitato Cerulli, per essere stato trovato con qualche
archibugio senza il relativo porto d’arme, ricordo che se quello sfortunato
facesse il “bracciale” come il novanta per cento della popolazione d’allora,
avrebbe dovuto lavorare trenta anni, senza mai mangiare bere vestirsi e soprattutto
ammalarsi. Certamente il Principe di Venosa, durante la stesura del testamento,
per fare un po’ di beneficenza, oltre a ricordarsi vagamente dello zio San
Carlo, capì che le bestemmie del Cerulli avrebbero vanificato le migliaia di
migliaia di messe che aveva ordinato per la salvezza dell’anima sua. Più degli
antenati del casato, Carlo da Venosa, aveva smodato attaccamento al danaro,
tanto è che nutriva persino antipatia per la povera gente che abitava nei paesi
dove i guadagni della giurisdizione erano scarsi. I poverissimi del vicino
paese di Montefuscolo (Montefusco), paradossalmente, proprio per questo furono
esclusi dalla distribuzione dell’elemosina, nel testamento già innanzi, più
volte riferito.
La Baronia di Montefuscolo,
insieme ai suoi casali e al Passo di “Venticane”, fu acquistata nel 1589 da
Fabrizio II° e Carlo Gesualdo, dal marchese di Chiusano, Federico Cacece
Tomacelli, per 115.000 ducati, di cui i Gesualdo parte versarono all’acquisto
e di altra parte restarono debitori, per cui si impegnarono a pagare
l’interesse del 7 per cento. Il Principe Carlo, durante la sua esistenza,
preferì pagare gli interessi senza mai cancellare quel debito. Allora gli
interessi correnti erano nell’ordine del 4%, ciò significa che il nostro
Principe disponeva di crediti con tasso superiore, oppure che così facendo
risparmiava sulla tassa di buonatenenza da versare a favore
dell’Università di “Montefuscolo”. All’epoca di Carlo Gesualdo e fino all’otto
agosto 1806 Montefusco fu il capoluogo del Principato Ultra, mentre il suo
carcere in epoca borbonica fu tristemente famoso per le inumane pene subite dai
patrioti del Regno delle Due Sicilie. Ebbene, siccome nel periodo feudale il
sopraddetto centro ospitava la Regia Udienza ed il Preside (corrispondenti all’attuale
Prefettura e Prefetto), nonché tanti altri uffici giudiziari, le entrate della
giurisdizione erano irrilevanti, ciò spiega la rabbia e le furberie del nostro
Principe, che privò i più deboli montefuschesi della istituzionata elemosina.
Ma Carlo, oltre a studiarle tutte, per aumentare le sue ricchezze, imponeva
intollerabili economie anche alla sua seconda moglie Leonora d’Este. In una
lettera del 1600, scritta dal cardinale Alessandro d’Este al fratello Cesare,
Duca di Modena e Reggio, si apprende che persino a Roma erano notori i
maltrattamenti che Carlo Gesualdo infliggeva a Leonora, causandogli i tanti
malanni legati alla infelicissima convivenza. “La prima delle sue infelicità
è che patisce del vivere strettamente (ossia nella massima economia),
essendo il principe immerso in una sordida avarizia che è cosa insopportabile”.
Dopo la morte di Alfonsino, l’unico figlioletto di Leonora e Carlo, i disagi
aumentarono al punto che la Principessa incaricò il suo conterraneo, don
Michele Neri, di chiedere al Duca di Modena suo fratello, un po’ di denaro,
avendo esaurito il suo peculio per pagare i medici di Napoli. Stando a
Gesualdo, oltre alle tirchierie e alle scostumatezze del marito, Leonora soffrì
nel castello gli eccezionali freddi di quei tempi, tanto che “gli traballavano
i denti in bocca” . Come sollievo nel tanto triste soggiorno gesualdino,
Leonora dopo la morte dell’unico figlio Alfonsino, si aspettava maggiore
considerazione da parte dell’arcivescovo Alfonso Gesualdo, il quale con
testamento del 26 Ottobre 1600 le donò un anello con rubino e un quadro
dipinto da prelevare a sua scelta nella pinacoteca privata del cardinale. La
beffa maggiore che Leonora subì dal marito, stà nel testamento, ove è spiegato
che il vitalizio e gli altri titoli concessi, erano automaticamente revocati
qualora la Principessa, per desiderio di vivere in pace, volesse allontanarsi
dai litigiosissimi parenti del defunto consorte. Il testo la obbligava al
rispetto della vedovanza e a restare nel Regno con la scelta di dimorare a
Gesualdo o Taurasi, o alla massaria San Antonio di Napoli. Ovviamente soltanto
a seguito di quello scritto si rese conto che il marito aveva un figlio non
legittimo di nome Antonio al quale la stessa Leonora doveva corrispondere
l’assegno di ducati 50 al mese. Anche in questo assunto Carlo non rispettò la
volontà del padre Fabrizio II° , il quale, nel testamento del 7 maggio 1591 gli
assegnava tutte le sue ricchezze e capitali finanziari gestiti dai banchieri
napoletani Ravaschieri, Oliati, e Grimaldi, lasciti che il figlio a sua volta
avrebbe dovuto trasmettere al suo primogenito o spurio. Evidentemente Antonio
Gesualdo, figlio naturale di Carlo era nato prima della morte di Fabrizio II°.
Dopo quella sgradita agnizione, spossata dall’ostilità che regnava
nell’ambiente del Castello di Gesualdo, Leonora si separò definitivamente dal
nostro centro Irpino. Da alcuni brani delle pagine 70 e 71 di Francesco
Vatielli: “Sulla fine del 1615 accompagnata dal marchese Ernesto Bevilacqua
ritornò definitivamente a Modena presso i suoi. Fu ricevuta la mattina del 13
Gennaio (1616) con tutti gli onori che comportavano il suo rango e l’affetto di
cui era stata sempre circondata dagli Estensi. Fece il suo ingresso accolta dal
Duca, dai Principi e da una folla di popolo con grande solennità di cortei e
con salve di gioia. Povera Leonora! Forse in quel momento avrà ricordato le feste che le
avevano fatte a Ferrara venti anni
 prima quando andò
sposa del Principe. Allora non avrebbe potuto immaginare quale cumulo di dolore
e di lutti avrebbe rattristato la sua esistenza di sposa e di madre, quali
avverse vicende si sarebbero abbattute sulla sua famiglia mutilata della
maggior parte dello stato avito e decaduta dalla sua grandezza. Trovò rifugio e
conforto nella tranquillità di una vita modesta e solitaria, dedicata a opere
di carità e di devozione.” Dal commovente epilogo del Vatielli pare che,
per Leonora, gli incubi sofferti a Gesualdo, fossero definitivamente rimossi:
non fu così. Gli esorcisti e stregoni che a Gesualdo furono mobilitati per
guarirla dai suoi malanni causati da avarizia, infedeltà, violenze e offese
alla dignità, l’avevano convinta che gli stessi esorcisti e stregoni potessero
servire per ragioni di Stato, quando si doveva rassicurare i cittadini sul futuro
dei loro sovrani: ma i disturbi psichici di cui soffrirono i figli del duca di
Modena e Reggio non dipendevano da cause ambientali ma da congenite malattie
della moglie di Cesare d’Este.
prima quando andò
sposa del Principe. Allora non avrebbe potuto immaginare quale cumulo di dolore
e di lutti avrebbe rattristato la sua esistenza di sposa e di madre, quali
avverse vicende si sarebbero abbattute sulla sua famiglia mutilata della
maggior parte dello stato avito e decaduta dalla sua grandezza. Trovò rifugio e
conforto nella tranquillità di una vita modesta e solitaria, dedicata a opere
di carità e di devozione.” Dal commovente epilogo del Vatielli pare che,
per Leonora, gli incubi sofferti a Gesualdo, fossero definitivamente rimossi:
non fu così. Gli esorcisti e stregoni che a Gesualdo furono mobilitati per
guarirla dai suoi malanni causati da avarizia, infedeltà, violenze e offese
alla dignità, l’avevano convinta che gli stessi esorcisti e stregoni potessero
servire per ragioni di Stato, quando si doveva rassicurare i cittadini sul futuro
dei loro sovrani: ma i disturbi psichici di cui soffrirono i figli del duca di
Modena e Reggio non dipendevano da cause ambientali ma da congenite malattie
della moglie di Cesare d’Este.
Poiché per molto tempo è prevalsa
la idealizzazione culturale dell’effimero, la storiografia locale si è occupata
della vita di Leonora, solo a partire dal matrimonio col nostro principe. Si sa
comunque che quando Leonora sposò Carlo anche lei era vedova e orba di un
figlioletto. In ogni modo l’Estense a Gesualdo fece l’esperienza più triste
della sua esistenza. Per tanto, siccome per la toponomastica paesana, raramente
si è trovata persona meritevole, anche per riparare in parte ai torti che per
circa 17 anni Leonora d’Este subì a Gesualdo, perché non le si intesta una
strada, magari, lungo il suo giornaliero itinerario per recarsi alla primitiva
Chiesetta della Madonna Delle Grazie?
Gesualdo 15 08
2005 Giuseppe
Mannetta





